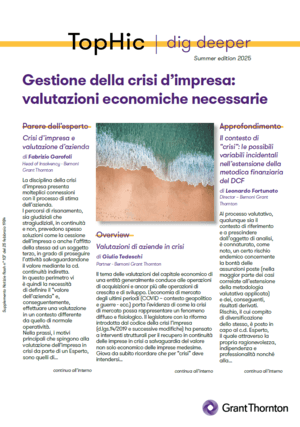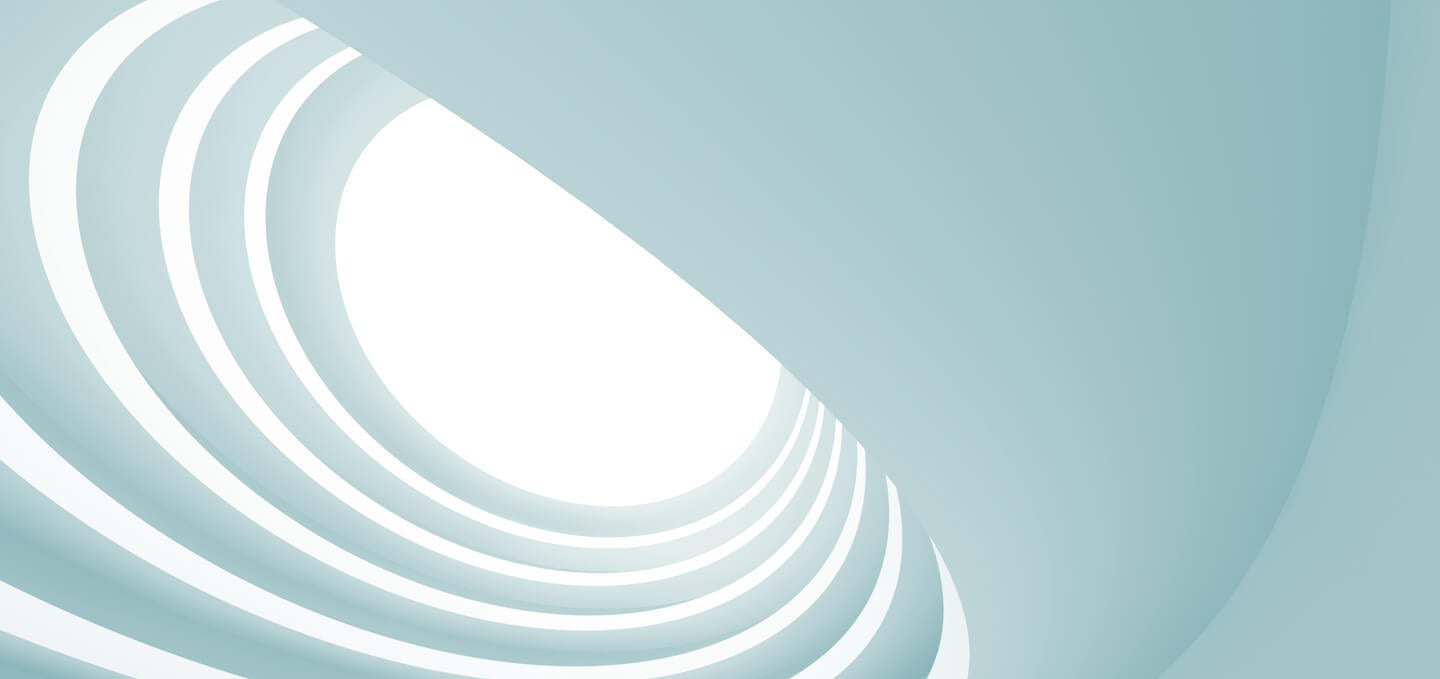
Il tema delle valutazioni del capitale economico di una entità generalmente conduce alle operazioni di acquisizioni e ancor più alle operazioni di crescita e di sviluppo.
L'economia di mercato degli ultimi periodi (COVID – contesto geopolitico e guerre - ecc.) porta l’evidenza di come la crisi di mercato possa rappresentare un fenomeno diffuso e fisiologico. Il legislatore con la riforma introdotta dal codice della crisi l'impresa (d.lgs.14/2019 e successive modifiche) ha pensato a interventi strutturali per il recupero in continuità delle imprese in crisi a salvaguardia del valore non solo economico delle imprese medesime.
Giova da subito ricordare che per “crisi” deve intendersi “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi” (art. 2, co. 1, lett. a) del CCCII). Viceversa, per “insolvenza” deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2, co. 1, lett. b) del CCCII)[1].
Sinteticamente, queste due definizioni, secondo una lettura normativa, stanno a indicare che la “crisi” costituisce un momento patologicamente anteriore all'insorgere dell'”insolvenza”. Come tale è una situazione in cui si può - e si deve - intervenire per cercare di risolvere la situazione di crisi e non incorrere irrevocabile situazione di insolvenza (che fisiologicamente conduce alla liquidazione giudiziale). L'individuazione dei più opportuni strumenti per una salvaguardia dell'impresa in crisi finalizzata al risanamento e alla continuità passa attraverso strumenti normativi che richiedono lo svolgimento delle valutazioni di cui qui si discute.
In altri termini le valutazioni di cui sopra rilevano anche nell'ambito della crisi di impresa a supporto degli strumenti che il legislatore ha previsto per organizzare il superamento della crisi, finalizzata al conseguimento di un riequilibrio della posizione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa.
La dottrina più qualificata ha affrontato immediatamente questo aspetto evidenziando come “… le conseguenze della crisi di impresa possono essere più o meno gravi in relazione a quanto tempestivamente è diagnosticato e a come è gestita”.[2]
Le valutazioni rilevano quindi non solo come strumento tecnico a supporto degli istituti di risanamento previsti dal CCII, ma anche quale strumento di gestione consapevole poiché una valutazione informata dell'azienda in crisi può rappresentare uno strumento decisivo di diagnosi e di gestione del declino in un'ottica di salvaguardia.
Non solo per diagnosticare la gravità della crisi, ma per individuarne le cause: una valutazione nella fase di gestione della crisi deve, infatti avere come scopo quello di individuare l'effettivo valore dell'attivo aziendale, punto di partenza (ma in prospettiva anche di arrivo) per la risoluzione della crisi.
Il ruolo del valutatore, poi, oltre a individuare la particolare finalità della valutazione impone una riflessione sull'indipendenza professionale; indipendenza, in linea di principio, sia dagli interessi di parte, sia dall'analisi dei piani di ristrutturazione che possono soffrire di distorsioni ma che rappresentano il punto di partenza quali fondamenta degli interventi da prendere a riferimento per le valutazioni.
In questo numero verrà pertanto sviluppato il pensiero dell'esperto (dott. Fabrizio Garofoli) che svilupperà l’analisi analitica delle fattispecie ove il legislatore del CCII richiede espressamente l'intervento di un esperto per lo svolgimento di valutazioni asservite alle distinte plurime procedure.
Seguirà inoltre un approfondimento (dott. Leonardo Fortunato) che avrà per oggetto l'analisi delle possibili metodologie di valutazione da attivare nello specifico contesto delle imprese in crisi finanziaria. Tenendo in debito conto criticità, prospettive e concreta applicabilità delle metodologie.
Per concludere, un’ultima riflessione sul tema che coinvolge i professionisti della nostra organizzazione chiamati a cimentarsi su queste tematiche. Quali i percorsi da compiere per poter svolgere una valutazione delle aziende in crisi? La prassi individua almeno quattro fasi: (i) l'analisi dello Stato di crisi, (ii) l'architettura dell'impianto valutativo, (iii) l'analisi del piano di risanamento, (iv) le metodiche di valutazione da scegliere ed applicare.[3] In particolar modo con riguardo all’ultima fase non deve essere sottaciuto che il valutatore deve innanzitutto considerare i rischi in relazione alle diverse configurazioni di valore oggetto della stima. Infatti, un'impresa in crisi richiede generalmente una ristrutturazione operativa e come tale più o meno intensa e rischiosa. L'approccio alla valutazione deve identificare bene il percorso attraverso il quale l'impresa intende realizzare la ristrutturazione. Da qui il rischio del piano in sé e il rischio di insuccesso del piano.
Il rischio in sé è riflesso in tutte le configurazioni di valore che vengono adottate e che si fondono su una prospettiva di continuità (valore recuperabile).
Il rischio di insuccesso viceversa è riflesso solo in alcune configurazioni di valore che si fondono su una prospettiva “mista” ovvero che può presupporre la riuscita e la realizzazione del piano (sia pur con diversi esiti possibili), ma anche una valutazione che presuppone una liquidazione della società.
Aspetti tutti questi che devono essere attentamente ponderati in quanto per questa tipologia di valutazione non sono automaticamente applicabili i modelli e le metodologie che caratterizzano la generalità delle valutazioni. È, infatti, più difficile trovare riscontri con valori di mercato o con attività comparabili e così pure elementi utili per stimare un costo di rimpiazzo.
Pur sempre un’attività “professionale” di natura interdisciplinare che richiede un elevato grado di attenzione.
[1] La norma induce a una lettura di carattere prettamente finanziario: l’inadeguatezza dei flussi finanziari ovvero l’impossibilità di far fronte al pagamento delle proprie obbligazioni. Non può però essere però sottaciuta l'affermazione comprovata secondo la quale oggettivamente una crisi finanziaria è una conseguenza di una crisi economica; come tale quest'ultima è temporalmente anteriore e anticipa quella finanziaria.
[2] In tal senso M. Bini “Le valutazioni delle aziende in crisi” EGEA 2025.
[3] OIV – Organismo Italiano di valutazione - Discussion paper n.1/25: “La valutazione delle aziende in crisi”