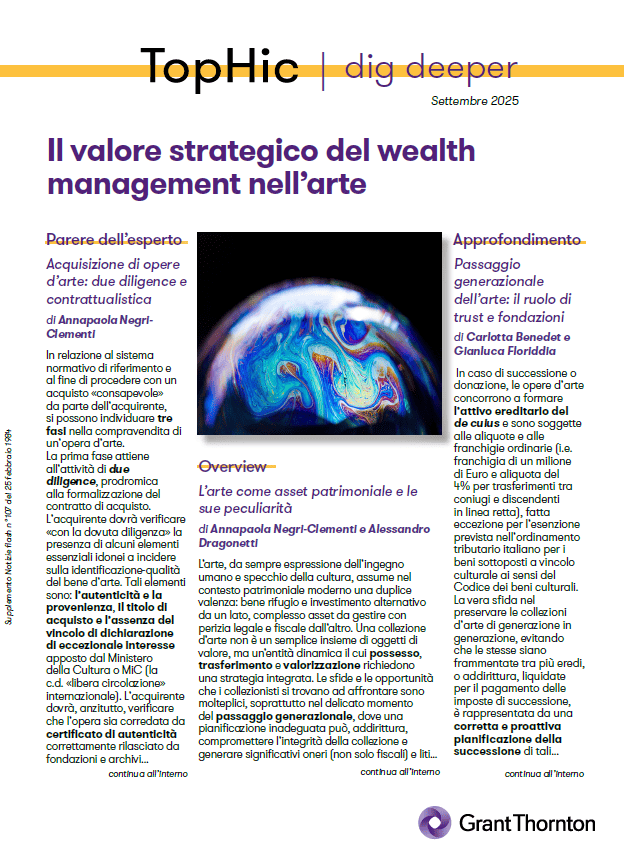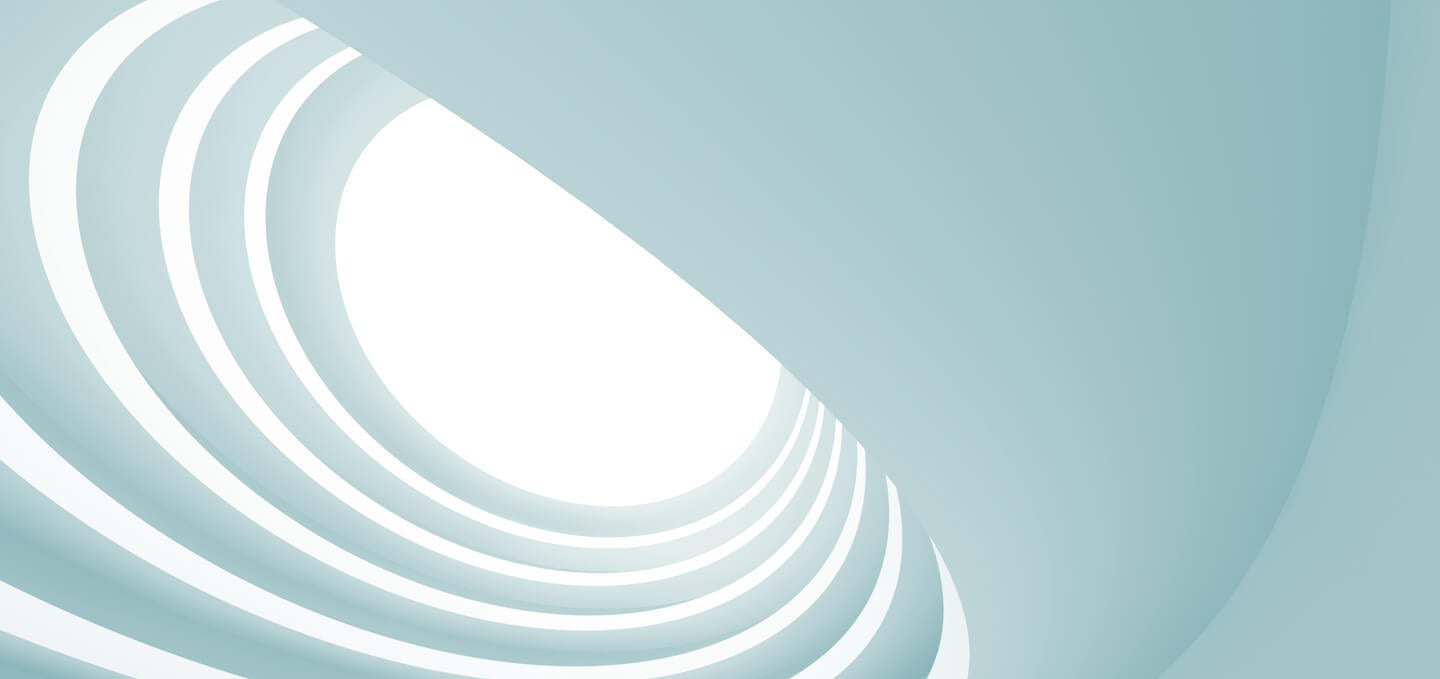
In relazione al sistema normativo di riferimento e al fine di procedere con un acquisto «consapevole» da parte dell’acquirente, si possono individuare tre fasi nella compravendita di un’opera d’arte.
La prima fase attiene all’attività di due diligence, prodromica alla formalizzazione del contratto di acquisto. L’acquirente dovrà verificare «con la dovuta diligenza» la presenza di alcuni elementi essenziali idonei a incidere sulla identificazione-qualità del bene d’arte. Tali elementi sono: l’autenticità e la provenienza, il titolo di acquisto e l’assenza del vincolo di dichiarazione di eccezionale interesse apposto dal Ministero della Cultura o MiC (la c.d. «libera circolazione» internazionale).
L’acquirente dovrà, anzitutto, verificare che l’opera sia corredata da certificato di autenticità correttamente rilasciato da fondazioni e archivi, o da perizie redatte da esperti universalmente riconosciuti (expertise). È importante poi controllare che l’opera provenga da transazioni o altri trasferimenti (a titolo particolare o universale), andando a ritroso nell’individuazione dei precedenti proprietari fino, ove possibile, al momento della creazione dell’opera (acquisto a titolo originario), accertandosi che il venditore sia legittimato a disporre dell’opera e che il bene non sia gravato da pegni, sequestri o contenziosi. Infine, verificare che l’opera possa circolare al di fuori dello Stato italiano in quanto non vincolata dal MiC perché eventualmente avente le caratteristiche di bene culturale.
La seconda fase riguarda la redazione del contratto di compravendita. Il contratto dovrà prevedere l’inserimento di talune clausole importanti per la tutela dell’acquirente. In particolare, dovrà contenere specifiche clausole di garanzia, con le quali il venditore garantisce espressamente all’acquirente, tra l’altro, l’autenticità dell’opera, di avere la piena ed esclusiva titolarità e disponibilità (anche agli effetti di cui agli artt. 1483 ss. del c.c.) e che l’opera sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (artt. 1490 ss. del c.c.) e libera da pegni, gravami, vincoli pregiudizievoli o diritti di terzi di qualsivoglia natura.
Infine, qualche nota d’attenzione va spesa su due ulteriori aspetti rilevanti, ma spesso poco considerati.
Da una parte, le clausole di garanzie relative al diritto d’autore e, in particolare, ai diritti patrimoniali di utilizzazione economica. Può accadere, infatti, che l’acquirente non acquisisca soltanto l’opera, ma anche singoli diritti di sfruttamento economico che possono circolare separatamente dalla proprietà materiale del bene. Tra questi, rientra il diritto di riproduzione dell’immagine dell’opera su cataloghi espositivi, materiali destinati al merchandising, siti web o profili social a fini promozionali. È importante ricordare che la riproduzione dell’immagine di un’opera d’arte costituisce uno dei diritti di sfruttamento economico esclusivi riconosciuti all’autore dalla Legge sul Diritto d’Autore. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tale diritto non si trasferisce automaticamente con la vendita dell’opera. Di conseguenza, se insieme all’acquisto non è stato ceduto anche il relativo diritto di riproduzione, il nuovo proprietario non potrà autorizzarne l’uso a terzi (come musei o gallerie). Saranno, invece, questi ultimi a dover richiedere una specifica licenza all’artista o ai suoi aventi causa per poter utilizzare legittimamente l’immagine dell’opera.
Dall’altra parte, la clausola di garanzia relativa allo stato di conservazione del bene e, quindi, la raccomandazione di allegare al contratto il cd. condition report. Quest’ultimo è un documento che definisce lo stato di conservazione di un’opera d’arte, contenente tutte le informazioni sulle condizioni fisiche inclusa la descrizione dei danni, il restauro e le riparazioni eventualmente eseguite. Tale rapporto contribuisce a evitare conflitti sullo stato dell’opera ed eventuali danni che l’opera potesse avere subito prima del trasferimento della proprietà.
Infine, tornando all’analisi giuridica della compravendita, la terza e ultima fase riguarda l’eventuale patologia del contratto la cui gestione dipende, di nuovo, dalla redazione dello stesso. Infatti, qualora, successivamente alla compravendita, l’opera dovesse risultare «non autentica», ossia dovesse sussistere una qualsivoglia «divergenza tra il bene trasferito e il bene dedotto in contratto», l’acquirente potrà avvalersi di rimedi giuridici diversi a seconda che egli abbia o meno previsto una clausola di garanzia di autenticità. In sintesi, l’acquirente potrà richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento per consegna dell’aliud pro alio, se l’«autenticità» è stata garantita dal venditore, o potrà esercitare l’azione di annullamento per vizi del consenso, se la vendita dell’opera d’arte è avvenuta senza garanzia del venditore sull’autenticità dell’opera. Tali azioni prevedono diversi termini di prescrizione e una diversa ampiezza del danno risarcibile.